La Puglia ha una storia ricca di lavori e mestieri antichi che raccontano le radici profonde della cultura locale. In un’epoca in cui l’industria e la tecnologia dominano la scena, è importante riscoprire alcune delle professioni che hanno plasmato la vita quotidiana dei pugliesi.
Molti mestieri tradizionali, spesso tramandati di padre in figlio, rappresentano oggi un patrimonio culturale prezioso ed è fondamentale preservare queste tradizioni, affinché possano continuare a raccontare le storie del passato e ispirare le future generazioni.
Alla riscoperta dei lavori e mestieri antichi in Puglia
Nei mestieri antichi, la manualità era basilare, con attività che si svolgevano quasi esclusivamente attraverso il lavoro fisico e ogni gesto e movimento erano frutto di esperienza e precisione.
Ogni artigiano metteva in gioco la propria creatività e abilità, spinto dalla necessità di guadagnarsi da vivere e prendersi cura della propria famiglia.
Il calzolaio: l’arte delle scarpe fatte a mano
Uno degli artigiani più emblematici del passato è il calzolaio (u scarpoire), una figura fondamentale in ogni piccolo borgo.
L’artigianato delle scarpe ha radici antiche, ma i calzolai pugliesi, ben noti quelli del Salento, sono celebri per la loro abilità nel creare scarpe in cuoio e in pelle su misura, robuste e di alta qualità. Accanto alla creazione di nuove calzature, si occupa anche della riparazione e del restauro delle scarpe.
Il calzolaio non si limita a seguire schemi preconfezionati, ma crea un prodotto personalizzato, adattato alle misure e alle esigenze specifiche di ogni cliente.
“U scarpoire foisc l’ scarp a l’alt e jd ve p’ l’ scarp rott.” (Il calzolaio fa le scarpe agli altri e lui va con le scarpe rotte). Questo detto di Gravina ha un significato che riguarda il paradosso e la condizione di chi lavora per gli altri, ma spesso sacrifica il proprio benessere o i propri bisogni.

Lo zappatore: il mestiere più duro dei contadini del Sud
Il mestiere dello zappatore (u zappatóre) è uno dei più antichi e fondamentali legati alla coltivazione della terra.
Il contadino zappatore, dopo anni di duro lavoro nei campi, finiva per ritrovarsi con la schiena ricurva. Era una condizione comune tra i nostri nonni, che svolgevano questo lavoro principalmente con la zappa.
Oggi, con l’introduzione delle macchine agricole, il lavoro manuale dello zappatore è diminuito, ma in alcune aree rurali e nell’agricoltura biologica continua a essere praticato per preservare la qualità del suolo e rispettare le tradizioni.
“La zappe de scennare iégne u panare.” (La zappa di Gennaio riempie il paniere).
Questo detto di Sammichele di Bari ha un significato legato alla stagionalità del lavoro agricolo e all’importanza di iniziare presto per ottenere buoni risultati.

Il falegname: maestro dell’arte del legno
Il falegname (lu falegname, mesciu d’àscia) ha sempre avuto un ruolo centrale nelle comunità rurali pugliesi e la lavorazione del legno è stata una delle prime arti dell’uomo.
Utilizzando legni pregiati come il ciliegio, il noce e l’ulivo, il falegname realizza mobili, finestre e porte, ma anche utensili per la vita quotidiana.
Per i nostri antenati, lavorare il legno non era solo una scelta, ma una questione di sopravvivenza. Dal legno venivano realizzati strumenti essenziali per la vita di tutti i giorni: dalle armi per difendersi, ai ripari che offrivano sicurezza, fino a ruote e ponti che collegavano mondi diversi.
“Falegname lùengu, firràru curtu.” (Falegname lungo, fabbro corto). Il detto leccese suggerisce una differenza tra lavori che richiedono una preparazione lunga e un processo meticoloso (falegname) e lavori più diretti e rapidi (fabbro).
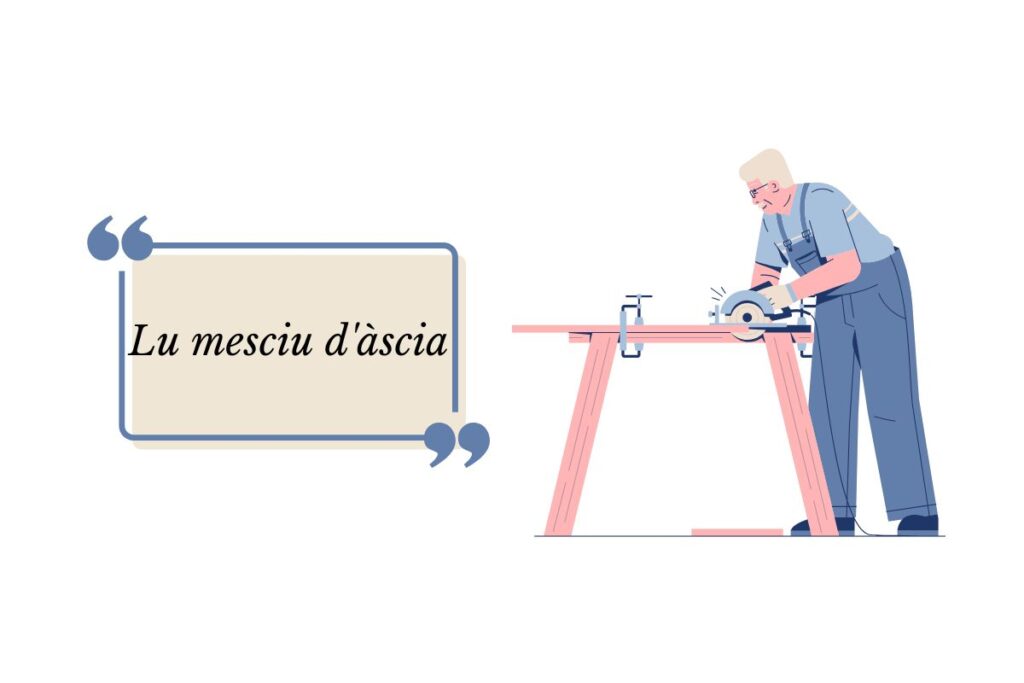
L’artigianato artistico del cestaio
In molte zone della Puglia, il mestiere del cestaio (u cestàere) è stato tramandato per secoli ed è sempre legato alla realtà contadina.
Realizzare cesti e panieri con materiali naturali come il giunco o il vimini era un’attività comune, soprattutto nei paesi dell’entroterra. I cesti venivano usati per raccogliere i frutti della terra, per la vita quotidiana e per i mercati.
Oggi questa tecnica è ancora praticata da pochi artigiani che creano cesti decorativi o funzionali, mantenendo viva la tradizione.
“Amme pèrze a Felippe ke tutte u panare.” (Abbiamo perso Filippo con tutto il paniere).
Questo detto popolare di Foggia è utilizzato quando si manda qualcuno a consegnare un oggetto ad una terza persona, e dopo un pò di giorni non si hanno notizie né della persona né dell’oggetto.
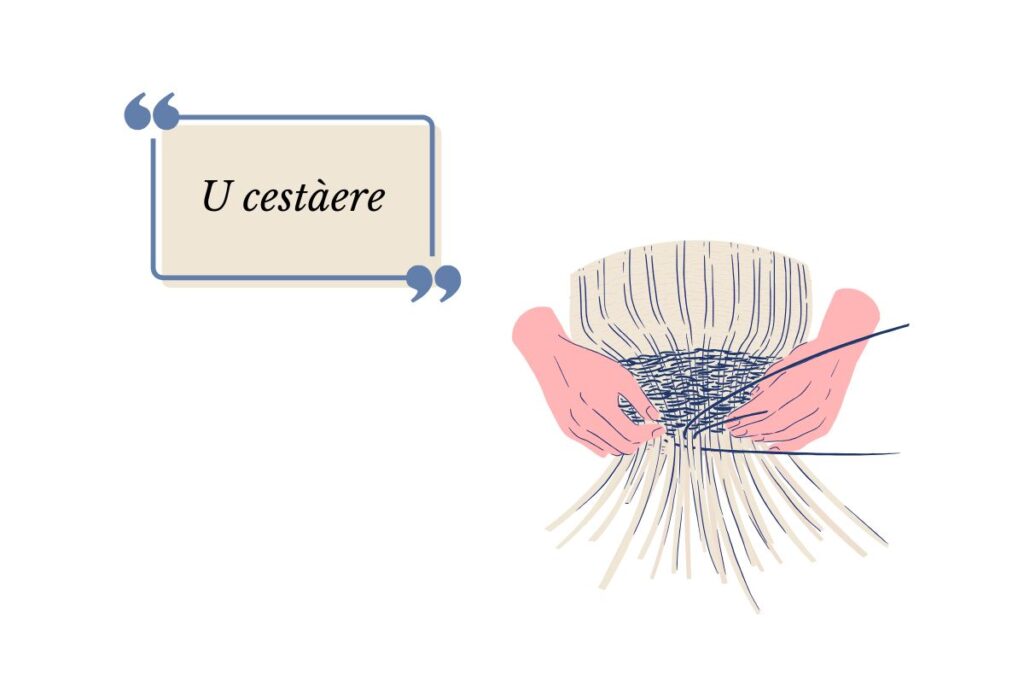
L’arrotino: un mestiere itinerante della tradizione pugliese
Con un carretto al seguito, trainato a piedi, l’arrotino (u mola fuerce) portava la sua mola, un oggetto fondamentale per affilare strumenti e utensili da taglio.
Le ruote del carretto, progettate per il trasporto, venivano sollevate durante il lavoro. La mola funzionava grazie a un sistema semplice ma efficace: un pedale collegato a una molla metteva in moto la ruota che iniziava a girare.
Con grande maestria, l’arrotino affilava coltelli, forbici e persino gli strumenti dei beccai, offrendo un servizio essenziale sia per le famiglie che per i professionisti.
La famosa frase: “Donne, è arrivato l’arrotino!” è un’espressione idiomatica italiana che ha radici nella cultura popolare. Originariamente, l’arrivo dell’arrotino significava che era il momento di farsi affilare coltelli e forbici.
Nel contesto più ampio della frase, viene usato spesso per indicare che qualcosa di nuovo o di interessante sta per accadere, o che qualcosa sta per essere “rimesso a posto” o “affilato”.
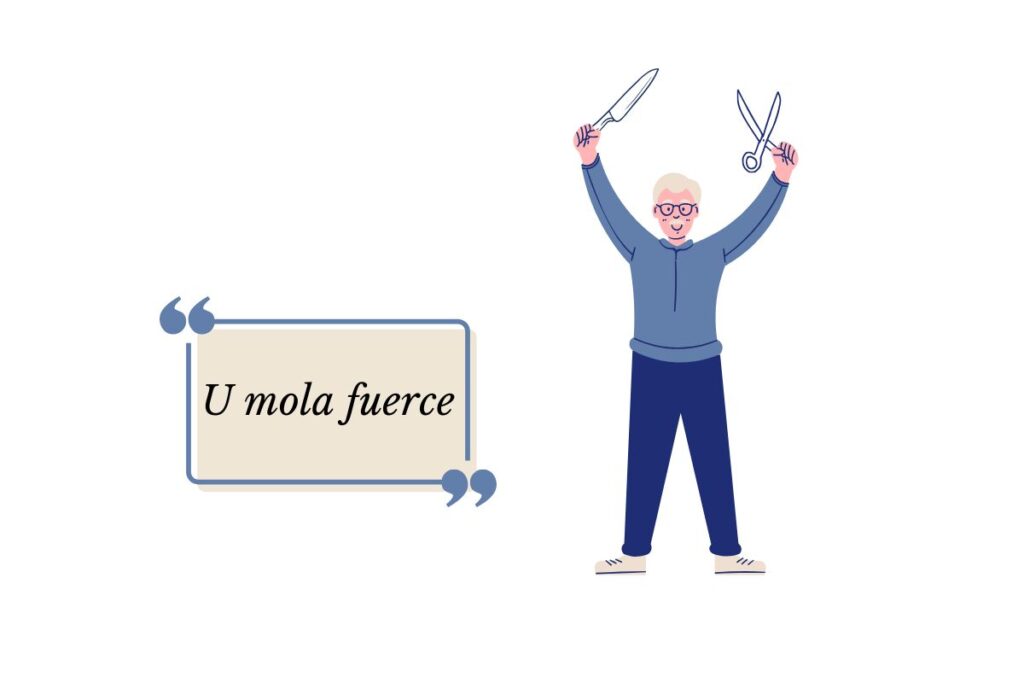
Il carbonaio: una tradizione rurale scomparsa
Il mestiere del carbonaio (u carvenare) era molto comune fino alla metà del XX secolo. Questo lavoro consisteva nel produrre carbone vegetale, ricavato principalmente dai tronchi di alberi di ulivo e mandorlo, che venivano abbattuti nelle campagne pugliesi.
A volte i carbonai dovevano spostarsi anche in zone lontane, seguendo l’usanza delle migrazioni stagionali.
Una volta ottenuto il carbone, con un carretto trainato da un asinello iniziava la vendita porta a porta.
“Com’ u carvoun; c’ u piggh veiv t’ cosc’; c’ u piggh murt t’ tèng.” (Il carbone se lo prendi vivo e acceso scotta; se lo prendi morto e spento tinge). Questo detto barese associa il carbone ad una persona cattiva, sempre nociva alla società.
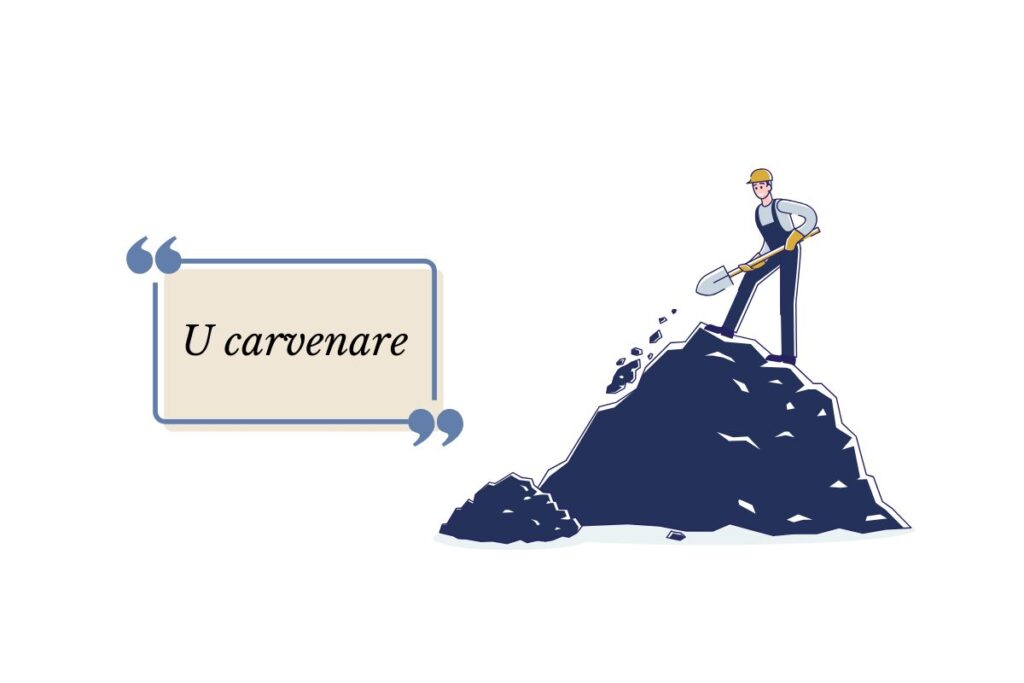
L’arte di plasmare la pietra dello scalpellino
U scalpëllìne, così viene chiamato in vernacolo, è un artigiano specializzato nella lavorazione della pietra.
Non si limita a tagliare e modellare la roccia, ma usa lo scalpello con grande maestria per creare opere di notevole dettaglio e bellezza. Molti di questi scalpellini, nelle loro botteghe, hanno sviluppato anche abilità nell’arte scultorea, creando vere e proprie opere d’arte, seppur spesso senza lasciare traccia del proprio nome, così come i cartapestai che con la loro arte unica plasmano la carta in forme straordinarie.
Il lavoro dello scalpellino è faticoso e mal retribuito. Un detto di Molfetta, infatti, dice: “fadghìmmë e fadghìmmë e schimmë sembrë péta-pétë” (lavoriamo e lavoriamo e stiamo sempre senza soldi).
Anche questa professione, con il passare del tempo, è andata progressivamente scomparendo.

Per preservare alcuni dei mestieri antichi della Puglia, è fondamentale il coinvolgimento delle nuove generazioni e il supporto da parte delle istituzioni locali.
Offrire opportunità di formazione, promuovere il turismo culturale e favorire l’incontro tra artigiani e giovani sono solo alcune delle soluzioni per garantire che queste tradizioni non vadano perse.
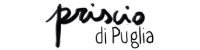



Articolo interessante, piacevole nella lettura e snello nella scrittura. Ricercate, ricordate i mestieri di un tempo che fu è un modo per onorare la memoria di artigiani e lavoratori instancabili e preziosi. Far conoscere ai giovani, e non solo, alcuni lavori e detti popolari del passato sono una ricchezza per la mente e per l’anima. 🙏👏👏👏
Grazie del commento – il lavoro della nostra redattrice Sara è proprio orientato al recupero della memoria identitaria di alcuni aspetti della cultura pugliese per poterla raccontare e far conoscere ai più.
Molto importante il recupero di una civiltà, dove la manualità regnava sovrana.
Ritengo pertanto interessante ed utile questo testo che dovrebbe avere diffusione soprattutto nelle scuole, insieme ai testi canonici di storia.
Brava Sara e grazie per queste perle che ci riportano indietro nel tempo, a recupero di una peculiarità della nostra avventura umana.
Grazie per aver colto ed evidenziato l’importanza del lavoro della nostra Sara nel recuperare questi tratti identitari della cultura pugliese. Torni a leggerci presto!